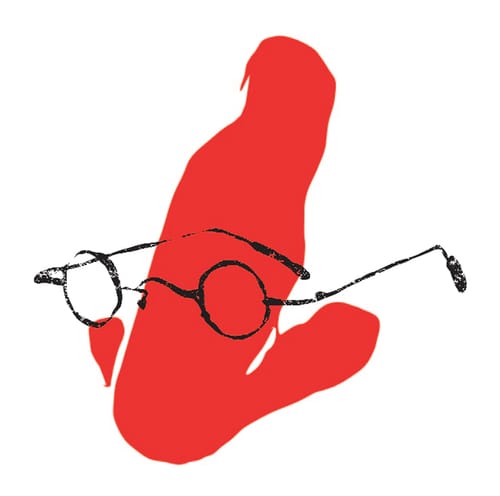
Seppelliamo l’università (prima che lei seppellisca noi)
NapoliMONiTOR - Wednesday, April 16, 2025 (disegno di martina di gennaro)
(disegno di martina di gennaro)Quello per un maggiore finanziamento dell’università pubblica italiana è senza dubbio uno dei tanti ritornelli che hanno compiuto la maggiore età riecheggiando nelle piazze italiane. Praticamente a vuoto: se c’è stata infatti qualche controtendenza al più generale trend di tagli alla spesa per la ricerca, è stato più per unicum occasionali (come le borse Pnrr post-emergenza Covid) che per la spinta arrivata dai movimenti di lotta.
Tranne rare eccezioni, a scandire la richiesta sono sempre quelli che, eventualmente, ne trarrebbero giovamento in termini di assunzione (quella categoria di precari che restano fuori per un pelo dai meccanismi della cooptazione). A manifestarsi, anche a questo giro di boa, infatti, sono stati quasi solo l’attuale generazione di dottorandi, gli assegnisti e qualche ricercatore più agée. Pochissime voci si levano dai palazzi dorati dei baroni, dei loro coscritti e delle anime pie, e ne è una prova tangibile il sostegno della Conferenza dei rettori (Crui) al colpo di grazia targato Anna Maria Bernini.
Men che meno protesta la base di giovani ricercatori che in questo quarto di secolo hanno transitato per l’accademia italiana, rimanendone tagliati fuori circa il novanta per cento di quelli che la tentano, cioè circa novemila dei diecimila dottorandi annui (di questi, il quattordici per cento circa ha intrapreso un esodo che li ha portati nelle università estere, mentre gli altri hanno trovato sbocchi in professioni diverse: il venti per cento, per esempio, ha ripiegato sull’insegnamento nel sistema scolastico).
Queste persone sono felicemente uscite dal sistema torbido dell’università, fatto di ricatti, vessazioni, angherie, battaglie fra correnti, favoritismi, nepotismi e un livello qualitativo sempre più basso. Ben quattro su dieci non ripeterebbero l’esperienza del dottorato (dato Istat, 2018) tanto che viene da pensare che forse è anche in ragione di questo che non arriva, da loro, alcun invito a un ripensamento, né alcun appello a favore dei finanziamenti per la ricerca.
Eppure farebbe la differenza, se oltre duecentomila ex-dottorandi (a fronte di centotrentamila strutturati accademici) lottassero per migliorare gli investimenti pubblici per quello che, nei loro anni migliori, hanno pensato potesse essere un modo utile di stare al mondo.
Da questo dato di partenza andrebbe forse analizzata la condizione attuale di una battaglia che, nella sua perenne ricorsività, rischia di perdere a ogni giro credibilità e richiamo. Se a difendere l’idea di aumentare i finanziamenti all’attuale università è soprattutto chi ne avrebbe un diretto interesse, l’alveo all’interno del quale ci muoviamo diventa quello di una lotta meramente sindacale, una lotta, cioè, fatta per migliorare le condizioni di chi è già dentro o che, al massimo, a questo mondo gira un po’ intorno. Non che questo sia sbagliato, anzi: riconoscerla in questi termini permetterebbe probabilmente un cambio di strategia che forse la renderebbe efficace. Ma così non va.
La richiesta di aumentare i finanziamenti alle università pubbliche, infatti, è sempre accompagnata da ragionamenti ideologici di pretesa di universalistica. Si cerca di argomentare rispetto al ruolo del sapere come strumento di crescita della società, o di convincere della necessità di investire nella ricerca per migliorare l’innovazione. Battaglie sacrosante, che dovrebbero trovare anzi ben più ampie alleanze sociali. Se solo fossero vere. Se cioè, davvero, l’università servisse a contribuire, anche per una piccola parte, al servizio pubblico cui pretende di farsi carico. Ancora: se fosse davvero tangibile queto presunto ruolo virtuoso dell’università nei processi democratici, nell’innovazione, nella produzione di conoscenza pubblica, il tema riguardante il suo futuro non travalicherebbe forse gli asfittici cortili delle facoltà?
Resta da chiedersi quali siano i motivi per cui l’università ha perso la sua vocazione, e quindi anche la sua funzione. La colpa è forse della burocratizzazione che schiaccia la vita lavorativa degli accademici? Della perenne competizione cui sono costretti i gruppi di ricerca per praticare la loro sopravvivenza? Che abbia colpa un modello intrinsecamente disciplinare e incapace di trasformarsi per rispondere alle sfide dell’oggi? Che la responsabilità risieda, ancora, nei meccanismi di cooptazione che asfissiano il ricambio basato sul merito, incorporando personale sempre meno capace e libere? Probabilmente, la risposta è nella somma di tutte queste e molte altre cose. Il fatto centrale, tuttavia, è che non possiamo più ignorare il gap che c’è tra società e università, quella distanza che isola e fa riecheggiare nel vuoto la richiesta di adeguare, per esempio, i finanziamenti agli standard europei.
Continuare a raccontare che possiamo spegnere l’incendio con un arredamento rinnovato, mentre fuori brucia l’intera città, non è utile alla causa, e venticinque anni di progressivo isolamento dovrebbero contribuire a farci venire il dubbio.
Davvero si crede possibile che in un contesto in cui il disinvestimento pubblico colpisce direttamente la vita del paese, nei crudi termini materiali di infrastrutture scolastiche, mediche, di mobilità e trasporti, di tenuta dei territori ai disastri ambientali e idro-geologici si possano stringere alleanze, e pretendere di mettere la salvaguardia dell’università tra le priorità delle lotte sociali? Allo stesso modo: si crede davvero che raggiungere standard di finanziamenti di livello europei contribuisca ad avere migliori università?
Naturalmente non si tratta di buttare al fiume il bambino con l’acqua sporca. Siamo tutti consci di piccole ma importanti sacche di resistenza, che con salti carpiati ed esercizi faticosissimi mantengono viva l’eredità della via italiana. Ma se parliamo di una crisi sistemica, con danni alle fondamenta, non possiamo di certo cullarci sulle rare riserve indiane delle “eccellenze”.
Ciò che dovremmo piuttosto fare è forse prendere atto della portata della sfida e contribuire a smantellare l’attuale ordine delle cose. Se il sistema è irriformabile, non lo sono le ragioni che gli hanno dato vita e l’hanno fatto esistere fino a oggi.
Non esistono scorciatoie: dobbiamo immaginare le universitas del domani, una evoluzione di quella di oggi che, agonizzante, muore. Rimanere aggrappati a piangerla e implorare i medici perché possa respirare altri cinque minuti sta facendo sfuggire di mano l’occasione di vederne rinascere i principi fondativi.
Gli Stati Uniti sono i precursori dei peggiori trend che, a scalare toccano gli altri paesi occidentali, che prontamente gli vanno a ruota. Tra gli obiettivi dell’amministrazione Trump, in continuità con le tendenze già intuite dalle forze di mercato, c’è la definitiva distruzione dell’università americana e la sua trasformazione in fondazioni private che con quei meccanismi (di mercato) funzionino. La destra ha colto, in America, la crisi dell’università, e la sua separazione dalle necessità del corpo sociale per minarne i principi fondativi; per mettere in dubbio, cioè, l’idea che il sapere e la scienza siano strumenti utili al miglioramento delle condizioni della specie umana. Stanno distruggendo l’università per trasformarla in uno strumento al servizio del mercato, approfittando della crepa aperta con la società per trarne vantaggio.
La destra mondiale sta dimostrando di avere, su questo come in altri campi, la carta vincente di volere immaginare il futuro. A differenza dei progressisti-liberali lavora ancora agli immaginari, piuttosto che aggrapparsi al mantenimento dello stato di cose presenti. Così è riuscita a concepire il superamento dell’università, chiaramente a favore degli interessi di mercato. E la sta praticando con misure draconiane.
Se le forze trasformative non si faranno carico di una capacità immaginativa all’altezza soccomberanno sotto gli stessi colpi, e l’unica differenza con gli Usa sarà nella tempistica: ci vorrà un po’ più di tempo per picconare una istituzione millenaria, elitaria e ancora molto radicata nella cultura europea, ma quel giorno arriverà, magari sull’onda di altre urgenze come un riarmo qualsiasi. Il solco è tracciato, e se non saremo capaci di cambiargli verso, ci resteremo seppelliti dentro. (lori sodo)
