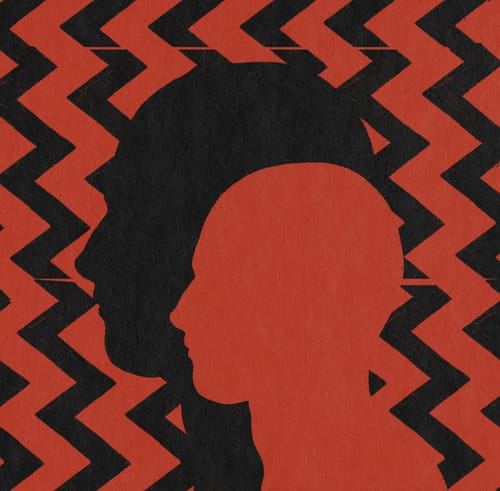
L’inizio di una cosa. Cronache e spunti dai giorni del Blocchiamo tutto
NapoliMONiTOR - Tuesday, October 7, 2025 (disegno di dalila amendola)
(disegno di dalila amendola)Un giornalista palestinese pochi giorni fa ha definito la settimana appena trascorsa “un’intifada italiana”. Eppure è difficile immaginare che queste masse di persone torneranno a radunarsi a breve. Chi ha protestato contro il genocidio condotto da Israele sin da ottobre del 2023, o anche da prima, si sente finalmente ascoltato; il dolore addizionale causato dal silenzio che circondava le manifestazioni di mille, duemila persone – nei momenti migliori cinquantamila – si è sciolto di fronte al milione in marcia a Roma il 4 ottobre, e già da prima con le centinaia di manifestazioni in tutte le città italiane, grandi e piccole. Ci sentiamo ascoltati; ma sapremo ascoltare? Le masse di persone mobilitate all’improvviso, sapranno adattarsi alle strutture spesso rigide dei cosiddetti “movimenti”? Non saranno invece i nostri movimenti a doversi adattare a loro? Vale la pena una riflessione rapida che ricapitoli cos’è successo, a partire da quello che abbiamo vissuto in alcune città in questi giorni, per ragionare su come non disperdere tutta questa forza.
È importante ricordare che se un milione di persone sono scese in piazza, è soprattutto perché il Pd, La Repubblica, i telegiornali della Rai e di La7 hanno deciso che era arrivato il momento di sdoganare la critica al genocidio per destabilizzare il governo, dopo aver taciuto o difeso gli aguzzini israeliani per due interi anni. Certo, questa non è l’unica causa. Il movimento è partito dai palestinesi in Italia, e dagli studenti universitari e medi. È stato alimentato da chi aveva fatto della Palestina la propria causa ben prima del 7 ottobre, che è riuscito a connettersi con chi, magari, è venuto al mondo più o meno negli anni in cui nasceva la campagna del Bds. Per mesi lo hanno tenuto in piedi insegnanti, ricercatori universitari, sanitari. E poi è salito di livello con il coinvolgimento dei sindacati, con l’avanguardia rappresentata dai portuali, improvvisamente coperta dai media grazie alla Flotilla. L’esplosione di quest’ultimo mese si deve al fatto che potentati di ogni genere – dal terzo settore alle gerarchie universitarie, fino al circo dello star system internazionale – hanno capito che parlare a favore della Palestina oggi può farti guadagnare terreno nell’opinione pubblica. Le manifestazioni oceaniche di questi giorni, ma anche l’incertezza radicale sulla tenuta di questa “intifada”, sono il prodotto di questo miscuglio. La domanda da porci è: che ruolo abbiamo avuto “noi” fino a questo momento, e che ruolo possiamo avere d’ora in poi? Ci sarà un seguito che possiamo propiziare, facilitare, spingere? Che ognuno declini il “noi” come preferisce.
Ironia della storia, il fischio d’inizio è arrivato da Genova, lì dove il ciclo di lotte del secolo passato si era interrotto. Da Genova il 31 agosto era partita la Flotilla, accompagnata da 40 mila persone; quella stessa sera uno dei leader del Calp, il Collettivo autonomo lavoratori portuali, legato a Usb, aveva annunciato il blocco dei porti nel caso che Israele si fosse permessa di toccare le barche. Al termine di un’assemblea partecipata da studenti, lavoratori e realtà solidali di tutto il paese, Usb proclama lo sciopero generale del 22 settembre. Dopo mesi d’inerzia, anche la segreteria nazionale di Filt Cgil annuncia uno “stato di agitazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori portuali a sostegno della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla”, chiamando ore di sciopero e manifestazioni per il 19 settembre. Nel frattempo, il Si Cobas chiama lo sciopero per il 3 ottobre nei termini di preavviso previsti dalla legge. Strutture politiche e sindacali di riferimento, deboli e in conflitto tra loro, devono fare i conti con una presa di coscienza collettiva, rincorrendo la rapida evoluzione degli eventi. Grazie al coinvolgimento dei portuali, l’attenzione si rivolge alla prassi del blocco delle merci e della circolazione, degli interporti e delle altre infrastrutture sensibili: autostrade, stazioni ferroviarie, aeroporti e tangenziali. Questo è ciò che avviene più o meno ovunque, con intensità e modalità diverse. La ricomposizione si realizza in piazza, in modo rocambolesco, e con una serie di strettoie, contraddizioni e problemi irrisolti.
Chi conosce gli ambienti portuali e della logistica sa che certe pratiche vengono da lontano, soprattutto in una città come Genova. Per boicottare l’economia genocida e la forza bellica di Israele, l’azione dal basso dei lavoratori, per quanto organizzati, non è sufficiente: l’iniziativa dei portuali non avrebbe mai potuto prescindere da una forza collettiva più ampia, da alleanze trasversali e da un appoggio sindacale indispensabile per lo sviluppo della lotta nel lungo periodo. Di questo i portuali discutevano da tempo, nel tentativo di appellarsi alla legge 185/1990 che vieta l’invio di armi ai paesi in conflitto; da mesi ne parlavano con i loro omologhi in altri paesi europei. Una volta create queste connessioni, improvvisamente la pratica del blocco si è diffusa in tutta Italia. Mentre Genova si blocca, anche a Salerno si creano ore e ore di disagi e interruzioni del traffico container. A Livorno si presidiano le banchine del porto per impedire l’approdo di una nave coinvolta nella logistica del genocidio, con il sostegno di migliaia di persone arrivate da tutta la regione. Anche a Napoli si tenta un’occupazione del porto. A Roma la piazza davanti alla stazione Termini è inondata da cinquantamila persone, che improvvisano un corteo che si riversa sulla tangenziale est, bloccandola per ore. Milano, che “non si ferma” sin dal corteo in risposta allo sgombero del Leoncavallo a inizio settembre, e contro la speculazione a San Siro, erompe in scontri dentro e intorno alla Stazione centrale. E così in decine di altre città d’Italia.
Dal 22 settembre sono scesi finalmente in piazza altri pezzi della società civile. I giovani che sfilano in corteo per la prima volta hanno colto di sorpresa le burocrazie sindacali e le strutture di movimento. Le persone bloccate dentro le macchine sui cavalcavia della tangenziale di Roma – come a Bologna – invece di insultare applaudivano. La paura dell’accusa di antisemitismo a chi criticava Israele è passata; il popolo sta con la Palestina, nonostante i potenti stiano con Israele. Il decreto sicurezza è un ricordo lontano.
Un momento di rottura della normalità quotidiana è avvenuto durante la manifestazione di lunedì 22 settembre, la sera del primo sciopero generale. A Torino, migliaia di persone hanno sfilato lungo corso Giulio Cesare, la direttrice che attraversa i quartieri popolari a nord della città. Scorreva il corteo e attivisti, studenti di superiori e università, cittadini del centro non erano percepiti come alieni, ma le loro istanze erano riconosciute dagli abitanti. Dai balconi s’alzavano applausi, urla, suoni di pentole al passaggio delle bandiere e dei cori contro Netanyahu. Il trambusto sembrava un’apertura. Non tanto per la possibilità di costruire un esile ponte tra classi sociali, tra mondi urbani distanti: il percorso per arrivare a questo è lungo, a malapena impostato. L’apertura sembrava stare nello sguardo stesso di chi applaudiva dai balconi o scendeva in strada. Immigrati, ragazzi di seconda generazione, persone abituate a subire una quotidiana oppressione, e razzista, potevano forse godere di una sospensione dell’ordine, farne esperienza, e chissà in futuro riprodurla ancora.
Dal giorno dopo, le iniziative sono diventate quotidiane. Il 24 a Torino si occupa la sede universitaria di Palazzo Nuovo, e lo stesso succede in diverse scuole. La sera si bloccano i binari di Porta Susa: partecipano soprattutto persone estranee al mondo militante, ma non per questo meno determinate a passare due ore sui binari. A Roma si occupano tre scuole e la Facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza. A Genova arrivano i delegati dei portuali di Grecia, Francia e Spagna per un “meeting internazionale dei porti” in cui si discute di come estendere i blocchi: annunciano che la Grecia sta preparando uno sciopero generale per il 10 ottobre. Il 27 si bloccano dieci container pieni di materiale bellico, al terminal Spinelli.
Tra l’1 e il 2 ottobre, con il blocco della Flotilla, i cortei si intensificano. A Roma la chiamata alla mobilitazione circola alle otto di sera: nel giro di due ore decine di migliaia di persone accorrono a Termini, improvvisando un corteo verso la sede del governo a Palazzo Chigi. Un cordone di guardie le blocca a piazza Barberini, ma retrocede quasi fino a via del Corso. La trattativa evidentemente prevede che si torni subito sui percorsi consentiti, nonostante la massa sembri pronta a raggiungere, per una volta, i palazzi del potere. Ma in una città che si sente sempre ostile, fascista, rancorosa, all’improvviso migliaia di persone si ritrovano sotto al traforo di via Nazionale, a manifestare a mezzanotte di un mercoledì lavorativo con i fumogeni, i canti, gli ottoni della banda. La frequenza delle manifestazioni è impressionante, così come i numeri. E non sono solo gli effetti dell’endorsement liberale: c’è una ritrovata disponibilità a impegnare il tempo libero dal lavoro, uscire dal comfort della quotidianità schermata, piena di bisogni indotti e diffusa indifferenza.
La sera del 2, mentre a Roma un nuovo corteo parte dal Colosseo, a Torino si parte da piazza Castello verso ovest. Il corteo è così lungo che l’ultimo tratto della coda si separa dalla testa e occupa ancora altre strade. Ci si coordina tra sconosciuti, si presidiano i passaggi agli incroci, si sperimenta l’autogestione come parte della contestazione. Anche tra cittadini perbene, trasgredire le regole è diventato legittimo.
Arriva il venerdì dello sciopero generale, il 3 ottobre. A Salerno il porto è bloccato dalla stessa Autorità portuale, ma sin dall’alba i lavoratori in sciopero presidiano il varco Ponente, con i facchini della logistica, le reti e i collettivi salernitani, i manifestanti propal e alcuni attivisti prevenienti da diverse città. L’intenzione è di entrare nel porto. Si aspetta l’arrivo del corteo studentesco, e ci si posiziona davanti alla Celere che chiude l’entrata. Durante gli scontri, una manifestante viene rinchiusa in una camionetta. Iniziano i presidi per reclamare il rilascio. Studenti e studentesse prendono tutto lo spazio, sono pronti a cambiare tattica se una non funziona; esprimono rabbia e insofferenza non solo verso il genocidio, ma anche contro il sistema di potere da cui si sentono oppressi, contro la Celere che è lì a rappresentarlo. La manifestante alla fine viene rilasciata con l’accusa di resistenza e oltraggio, il presidio diventa un corteo. Si parla a lungo di quanto sia più facile, rispetto a Napoli, organizzarsi sul momento e in modo orizzontale; si discute di partecipazione, obiettivi, forme organizzative; e sul ruolo dei più grandi rispetto ai giovani, ma anche su come interpretare tutto questo.
A Milano il corteo si divide, il percorso della Cgil si separa da quello dei sindacati di base, mentre uno spezzone di militanti improvvisa un corteo selvaggio che contribuisce a bloccare l’intero quadrante nord-est della città. Gli spezzoni si ritrovano a Città Studi, lungo viali di solito attraversati distrattamente da studenti, docenti e personale amministrativo delle università: striscioni vengono arrotolati, appartenenze saltano nell’eccitazione di riprendersi le strade e diventare marea. A Roma, di nuovo una giornata di sole accompagna la manifestazione sulla tangenziale, anche se stavolta era stata chiusa preventivamente: la stessa azione che sembrava di rottura solo pochi giorni prima, ora appare un diversivo per impedire il blocco dei palazzi del potere. Ma il corteo è enorme, la testa incontra la coda, circondando polizia e carabinieri in un anello sopraelevato. Mentre il traffico si blocca, le persone finalmente si incontrano, in una città che sembra fatta apposta per impedirlo.
Siamo abituati ormai che i cortei non partono mai puntuali, visto che i numeri non sono quasi mai dalla parte nostra. Questi cortei hanno una portata diversa: bisogna partire presto, anche prima dell’ora fissata, perché la piazza non ci contiene. Le azioni non sono di avanguardia, ma dichiarate e condivise via social o dalla camionetta del corteo: obiettivi chiari e tempi utili per tutelarsi e scegliere che fare. Questo rende la lotta accessibile e la connota di forme radicali nuove e larghe. Bisogna continuare a domandarsi quali siano le forme utili di conflitto per un movimento così ampio, ricordandosi che forse il nostro sguardo deve cercare visioni di rottura e di lotta diverse da quelle che abbiamo vissuto e sostenuto negli ultimi anni.
La manifestazione nazionale del 4 ottobre non c’è bisogno di raccontarla. Piazzale Ostiense era ancora pieno mentre piazza San Giovanni già si riempiva – tre chilometri di fiume umano senza testa né coda, quasi più una festa che una protesta, dove i bambini delle scuole gridavano “sciopero sciopero”, gli adolescenti imparavano a tenere fumogeni e megafoni, e i vari gruppi militanti mostravano quello che sapevano dire e fare al resto del paese. Una canzone romana dal titolo Ma che razza de città a un certo punto dice “e t’accorgi tutt’a ‘nbotto che so’ tanti…”. I giornali naturalmente si fissano sul gruppetto di poco più che ventenni che si è staccato dal corteo per rovesciare qualche cassonetto, e che la Celere ha schiacciato contro la cancellata di Santa Maria Maggiore per identificarli uno a uno; non riportano le migliaia di persone tornate nella zona dal corteo per aiutare i fermati, ma soprattutto non trovano neanche una vetrina rotta per mostrare la “devastazione”. Nel frattempo i fascisti di Casapound fanno una scorribanda in un bar di piazza Vittorio, aggredendo e picchiando a casaccio, anche gente con i bambini al seguito: polizia e giornalisti, non pervenuti.
Dopo le manifestazioni più grandi della nostra vita, che abbiamo vissuto con leggerezza, facendoci portare nella rottura dell’ordinario impulsivamente, di pancia, ora l’euforia inizia a lasciare spazio alla necessità di fare ordine e ragionare. La domanda che risuona ovunque, naturalmente, è cosa fare per evitare che questo movimento venga depotenziato, incasellato, spento. Mentre la quotidianità intorno a noi si ricostruisce, ragioniamo soprattutto a partire dalla certezza che questa potenzialità esiste, e che può risvegliarsi. La forza di una mobilitazione ampia, nonostante le sue contraddizioni, avvicina mondi e immaginari distanti e può generare cortocircuiti impensabili. Ma ci aiuta anche a capire i nostri limiti. Cosa non siamo stati capaci di comunicare finora? Cosa possiamo comunicare? Cosa possiamo imparare?
A partire dalla prassi del blocco, queste mobilitazioni mandano un messaggio esplicito al modello economico che legittima il genocidio. Al centro del discorso c’è lo sciopero del carico e scarico di armi e l’obiezione di coscienza. I portuali per continuare a reggere il peso e i rischi del loro impegno hanno bisogno non solo del sostegno popolare, ma anche dell’alleanza con i lavoratori delle altre categorie che operano nella filiera del trasporto e che concorrono al viaggio internazionale delle merci militari e al loro transito nei porti. Il sistema che ci opprime si rivela strettamente legato a un genocidio; ne ha bisogno, lo difende, lo alimenta. Per fermare l’uno, dobbiamo fermare l’altro, e viceversa. L’arbitrarietà della “giustizia” italiana richiama e protegge quella di Israele, come si vede nel caso di Anan Yaesh; il disprezzo di Israele per il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi, tutelato dai trattati internazionali, si riflette sì nelle parole di Antonio “fino a un certo punto” Tajani; ma anche, in piccolo, nella violazione strutturale dei diritti di base da parte dello stato italiano, con gli sfratti, le intollerabili condizioni carcerarie, i Cpr, le residenze psichiatriche.
L’indignazione e la rabbia per quello che sta avvenendo al popolo palestinese richiedono il blocco delle esportazioni militari verso Israele, la rottura dei rapporti diplomatici, un boicottaggio efficace che colpisca gli interessi militari ed economici israeliani. Ma il genocidio a Gaza è collegato con il nostro quotidiano impoverimento, con il controllo capillare a cui è soggetta qualsiasi voce di dissenso, con le politiche di gestione dei fenomeni migratori e di militarizzazione e privatizzazione delle città, con l’uso militare della ricerca universitaria, con la manipolazione dell’opinione pubblica e la corruzione sistematica dei politici. Il boicottaggio dell’economia israeliana intacca lo stesso ciclo di produzione e consumo su cui si basano le nostre vite, di conseguenza lo stesso capitalismo.
I blocchi potrebbero essere anche blocchi della nostra normalità, dei nostri schemi concettuali acquisiti. A volte chi milita da tempo per cambiare il mondo finisce per mirare più a mantenere inalterati i propri metodi e il piccolo potere che si è conquistato. Chi è arrivato ora, invece, per quanto si possa meritare i “dov’eravate quando noi…?”, potrebbe essere portatore di strategie e idee nuove. Ma allora, chi mobilita chi? Chi guida le mobilitazioni? Un movimento così grande per la Palestina, per cominciare dovrebbe essere guidato dai palestinesi, più che dalle “strutture” di movimento, per evitare di riprodurre logiche coloniali anche tra di noi. E le nuove ondate di manifestanti non devono essere indotte ad adottare i “nostri” metodi di lotta; siamo noi, che abbiamo protestato sin dalla fine del 2023, o anche da prima, a doverci adattare a loro, se non vogliamo disperdere questa energia. Ma per farlo dobbiamo capire quali sono le forze interne che bloccano noi, invece di bloccare la città; cosa trattiene la nostra forza, e quindi la forza delle masse che potrebbe crescere ancora, impedendo di traboccare, di esprimere appieno la volontà condivisa di spezzare davvero l’oppressione. Da soli, “noi”, chiunque siamo, non possiamo farcela. Se davvero vogliamo un’intifada pure qua, come prima cosa dobbiamo metterci in ascolto. (redazione monitor)
