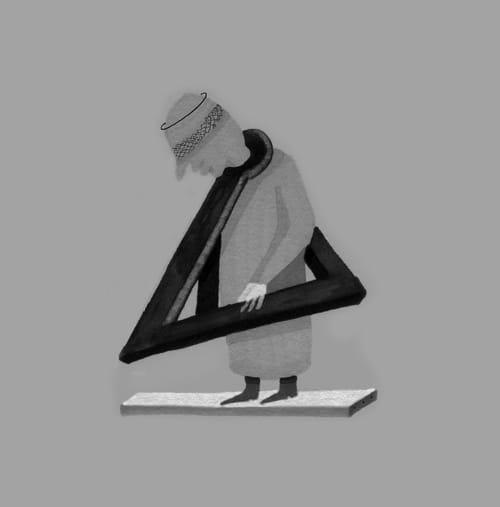
Studiare e insegnare a Gaza durante la guerra. Intervista ad Asmaa Abusamra
NapoliMONiTOR - Tuesday, January 7, 2025 (disegno di cyop&kaf)
(disegno di cyop&kaf)Asmaa Abusamra è una docente universitaria. Nel marzo 2024 ha lasciato la Striscia di Gaza per andare in Norvegia nell’ambito del progetto Scholars at Risk (SAR).
Mi ha dato appuntamento alla Biblioteca Centrale dell’Università di Oslo. L’intervista si svolgerà al terzo piano ma non prendiamo l’ascensore «perché da quando è cominciata la guerra non riesco più a stare in spazi stretti». Arriviamo in una sala riunioni con larghe finestre che mostrano i palazzi vicini e lei mi indica quello più alto: «È il Policlinico universitario, ogni tanto un elicottero si alza dal tetto e a me viene l’ansia perché il rumore mi ricorda quello dei droni che sono la colonna sonora costante di ogni giorno a Gaza».
Mi fa accomodare e si allontana per prendere caffè e acqua. Al suo ritorno, Asma mi racconterà della vita della gente di Gaza durante la guerra iniziata il 7 ottobre 2023, e di come l’educazione e l’insegnamento sono tra le poche cose a cui aggrapparsi per restare umani durante il massacro.
«A Gaza prima della guerra c’erano diciassette istituzioni universitarie e circa ottantottomila studenti immatricolati. Noi palestinesi siamo fieri del fatto che abbiamo il più alto tasso di iscritti all’università in tutto il mondo arabo. La mia si trova nella parte sud di Gaza City, vicino al corridoio di Netzarim. Fino a settembre 2024 alcuni edifici erano ancora in piedi e si poteva fare lezione, ma a settembre Israele ha raso al suolo tutto.
«Io sono una professoressa di Education Management allo University College of Applied Sciences of Gaza. Sono nata nel nord della Striscia e la mia famiglia, il mio lavoro e la mia vita, tutto ciò che mi appartiene è a Gaza. Vivevo nel quartiere di Shejayah, che era già stato bombardato durante la guerra del 2014. All’epoca la nostra casa subì qualche danno alle finestre, ma dopo una settimana siamo potuti rientrare. Il 7 ottobre avevo capito immediatamente che questa volta sarebbe stato molto diverso».
La interrompo per dire che altra gente da Gaza con cui ho parlato non si aspettava una reazione israeliana così devastante dopo il 7 ottobre. «Io invece l’ho capito subito – spiega – perché ho visto tante guerre da quando sono nata. Di solito la gente di Gaza sa che tipo di reazione aspettarsi da Israele, e molti speravano che sarebbe stato come le altre volte. Io mi sono resa conto subito che questa volta era diverso, che avevano bisogno di una scusa per fare qualcosa di molto peggio. Avevo capito che la punizione di Israele non sarebbe stata raddoppiata o triplicata come le altre volte, ma sarebbe stata decuplicata.
«Dissi a mia madre e a mio padre qual era la mia sensazione, ma all’inizio non mi presero sul serio. In ogni caso dovevamo andarcene, ma dove? Noi conosciamo solo Gaza e abbiamo qualche parente al sud, ma come fare a traslocare in quella situazione? Abbiamo preso qualcosa, la mia famiglia pensava che in un paio di settimane saremmo tornati a casa. Io presi il mio computer e andammo a Nuseirat, ma anche lì non era sicuro per niente, anche lì c’era la guerra. Arrivammo a piedi il 15 ottobre e c’erano scene di panico, centinaia di migliaia di persone che si muovevano verso sud e Israele bombardava anche chi scappava. Erano bombardamenti a caso, non potevamo sapere chi sarebbe stato il bersaglio. Alcuni miei parenti scamparono per un pelo alle bombe e si unirono a noi. Arrivati a Nuseirat siamo rimasti solo due settimane perché vedevamo le bombe esplodere a duecento metri da noi, le porte e le finestre della casa dove eravamo vennero distrutte, così a novembre fummo costretti a rifugiarci in una scuola.
«Io ho quarantatré anni e nella mia vita non ero mai stata rifugiata in una scuola durante i bombardamenti. Questo ha aggiunto altro dolore perché non era facile convivere con altre trentacinque persone sconosciute in una stanza grande quanto un’aula scolastica. Per questo motivo andammo a Rafah, e lì non conoscevamo nessuno e non c’era né acqua né cibo.
«Quando dico che non c’era cibo intendo dire che non avevamo né pane né acqua. Io sono la sorella più grande e ho sempre provveduto io alla mia famiglia. Mio fratello ha due figli e sua moglie era incinta in quel momento quindi doveva pensare a loro. Trovare da mangiare era diventata la nostra priorità, per cui ogni giorno mia sorella e io ci mettevamo in fila all’alba, una per il pane e l’altra per l’acqua. A volte tornavamo soltanto a notte fonda. Comprare il pane era troppo costoso».
Mentre Asmaa mi raccontava queste cose, ho ripensato alle parole che mi ha detto un’altra persona che era a Gaza in quei giorni: Israele ha bombardato e distrutto tutti i bancomat nella Striscia di Gaza. Per comprare cibo al mercato nero la gente che ha parenti all’estero e qualche soldo sul conto è costretta a versare i soldi sui conti di alcune famiglie di trafficanti che, con metodo mafioso, si tengono i soldi e forniscono cibo a prezzi altissimi: un uovo può costare anche due euro. Quando si parla di crisi umanitaria a Gaza si parla di situazioni come questa, e il vuoto di potere causato dalla guerra ha tolto ogni riferimento istituzionale alla popolazione.
«Era il caos. Se penso all’anno scorso penso solo al caos che vivevamo e al fatto che nessuno aveva a cuore la popolazione. Ognuno doveva pensare a sé stesso. Siamo rimasti a Rafah per duecento giorni, sette mesi».
Anche in questo caos Asmaa ha ricominciato a fare ciò che aveva sempre fatto: fare ricerca e insegnare, cercando di tenere insieme la comunità accademica di Gaza. «Mi sono messa a scrivere. Per tre mesi il mio laptop è rimasto spento perché non avevamo elettricità. A Rafah riuscimmo a trovare una presa per caricare computer e cellulare e ho cominciato a scrivere un articolo accademico, il titolo è Brain Drain or Brain Circulation. Mi sono chiesta cosa sarebbe successo alla comunità accademica di Gaza, cosa potrebbe succedere se tutti gli accademici lasciassero Gaza con permessi umanitari.
In quei giorni mi sono resa conto di quanto sia un privilegio avere internet, quando ho potuto ho aperto Facebook e ho visto le foto di moltissimi miei colleghi uccisi nelle settimane precedenti. Almeno quarantacinque persone, tutte uccise con la loro famiglia perché noi a Gaza diamo molto valore alla famiglia e stiamo sempre insieme. Tutte queste persone, io le conoscevo da vent’anni, ho visto crescere i loro figli, ed è molto difficile parlarne al passato».
A questo punto dell’intervista Asmaa apre il computer e comincia a mostrarmi immagini della sua università. Laboratori nuovi di zecca, postazioni di realtà virtuale e strumenti tecnologici. Impressionato, esclamo: «Ma che bella! Molto più avanzata della mia università a Palermo!». Asma mi racconta che c’è stata, che le è piaciuta ma che il cibo non è buono. Ridiamo e le dico che di solito la gente dice il contrario. A lei non piacciono la pasta e la pizza, però il pesce le è piaciuto.
«Ho viaggiato molto nella mia vita, ho fatto il dottorato in Indonesia e sono stata a insegnare in Turchia, in Belgio, in Malesia, in Francia. Ma casa mia è Gaza e non me ne sarei mai andata. A dicembre 2023 i miei amici e colleghi norvegesi mi hanno detto che c’era la possibilità di venire qui con un visto per accademici, ma io non avevo la minima intenzione di andarmene e lasciare i miei genitori da soli. I miei amici hanno insistito e hanno detto che ci avrebbero pensato loro a fare tutta la parte burocratica, e poi avrei potuto decidere se partire oppure no. La pratica è andata a buon fine e a gennaio 2024 sarei potuta partire ma non volevo andarmene. Rimasi a Rafah per tutto febbraio finché a marzo mia madre mi disse: “Asmaa, qui non sei utile. Tu devi essere fedele a ciò che sei. Vai, continua la tua carriera e da fuori potrai aiutarci più di quanto tu possa fare da qui”. A quel punto mi sono convinta anche perché non lavoravo e non avevo più soldi».
Per arrivare al Cairo e da lì raggiungere la Norvegia, Asmaa ha fatto come tutti i circa centomila abitanti della Striscia che sono riusciti ad andarsene: ha pagato cinquemila dollari a una organizzazione egiziana per attraversare il valico di Rafah. Poco dopo la sua partenza, Israele ha occupato il corridoio di Filadelfi e oggi nessuno, neanche pagando, può scappare.
«Adesso sono qui a Oslo con una sensazione che molti chiamano “survivor guilt”, il senso di colpa di chi è sopravvissuto. Quando la gente mi chiede: “Come stai Asmaa?”, io rispondo: “Quale Asmaa? Quella che vive in Norvegia o quella che è rimasta a Gaza?”.
«Sono in Norvegia con un permesso temporaneo di un anno, non so cosa accadrà dopo. Sto già cominciando a cercare lavoro ma non è facile in queste condizioni. L’unica cosa che mi dà forza è che devo essere attiva e sveglia per aiutare la mia gente. Io lavoro all’università da vent’anni, ho cresciuto generazioni di studenti. Durante ogni guerra, sotto le bombe, lo studio e la ricerca erano le uniche cose che riuscivano a farci superare i nostri problemi. Ho sempre insegnato ai miei studenti che l’educazione è libertà. Siamo occupati da Israele ma lo studio permette alla tua mente di essere libera, e anche al tuo corpo. Uscire da Gaza non era facile neanche prima della guerra, non era facile neanche per un topo o per un gatto passare il confine, ma se io e molti miei colleghi abbiamo potuto viaggiare è stato solo grazie all’università e alla ricerca. Di recente sono stata invitata da una università tedesca, in Germania non è facile per noi palestinesi ora, ma ho avuto la fortuna di trovare persone disposte ad ascoltare. La direttrice del dipartimento che mi ha invitata mi ha detto: “Noi cerchiamo di preparare gli studenti a capire il mondo, ma in questo momento mi fanno domande a cui non so rispondere, per questo motivo ti ho invitata, perché penso che tu sappia rispondere”; e per questo motivo io continuo a parlare in pubblico, anche se a volte mi sento schiacciata dalla situazione che vivo, comunque la sento come una responsabilità per proteggere la nostra umanità e la nostra storia collettiva.
«A Gaza abbiamo creato tante università con lo scopo di preservare la nostra identità e la nostra cultura. Oggi tutte le diciassette università sono state distrutte ma tutte continuano a lavorare! Siamo nel mezzo del primo semestre e le attività vanno avanti. Nella mia università c’erano undicimila studenti immatricolati, oggi novemila di loro stanno continuando a studiare e a dare esami online; anche se non abbiamo server continuiamo a studiare. Abbiamo ricevuto dall’estero donazioni per mantenere i server per la didattica a distanza. I professori insegnano senza stipendio perché i nostri stipendi li pagavano gli studenti che oggi ovviamente non possono pagare. Anche a Rafah abbiamo messo su una scuola e sotto le bombe facevamo lezione ai bambini più piccoli.
«La gente fuori pensa che Gaza prima del 7 ottobre fosse un campo di concentramento, ma non è vero. Certo, eravamo sotto occupazione, ma avevamo librerie, università, biblioteche, ristoranti, eventi culturali, la gente andava a rilassarsi in spiaggia. Noi avevamo creato una struttura per l’apprendimento di materie tecniche a Gaza: laboratori per formare meccanici, dentisti, estetisti, per dare lavoro ai ragazzi. Avevamo da poco inaugurato queste strutture e ora è tutto distrutto. Dietro ogni macchinario e apparecchio tecnologico c’è una storia, un lavoro, un progetto che ho seguito personalmente. Vedere tutto distrutto mi fa piangere il cuore, sapere che le persone che hanno lavorato a tutto ciò sono state uccise è qualcosa di irreale, fatico ad abituarmi».
Mentre parliamo, Asmaa continua a mostrarmi le foto dell’università, i video dei suoi studenti e altri ricordi dei mesi di guerra a Rafah. Mi mostra la foto di sua nipote, Zeina, che oggi ha cinque mesi. Sua cognata scoprì di essere incinta due settimane prima del 7 ottobre. Oggi Zeina è denutrita e non ha ospedali dove andare per le cure pediatriche.
«Nessuno merita di soffrire ma in questo momento vogliono toglierci anche il diritto di piangere e di vivere il lutto. Quando ho pubblicato i video delle conferenze che ho fatto qui, ho ricevuto insulti e minacce, mi hanno scritto via mail che la gente di Gaza si merita di essere distrutta. La verità è che in questo momento non ci sono due fazioni contrapposte sul terreno, c’è solo un esercito che sta bombardando la popolazione civile. Non è una guerra tra due eserciti, è un massacro.
«In questo momento non ci sono istituzioni a cui affidarsi, non possiamo neanche fuggire. Ci basterebbe avere lo stesso trattamento che hanno avuto i profughi ucraini, la libertà di raggiungere l’Europa o di muoverci liberamente, ma è ancora impossibile. Io non mi considero una rifugiata, sono stata costretta a fuggire e non avrei mai voluto lasciare Gaza, sono qui contro la mia volontà e il mio obiettivo è tornare a Gaza perché la mia vita è lì. Ma non voglio tornare solo perché costretta da un visto umanitario scaduto. Sono stanca e non voglio che i miei genitori soffrano ancora. A Rafah avevamo almeno dei muri intorno a noi, oggi ci sono le tende, e se arrivano le bombe la gente rimane bruciata viva, distrutta, vaporizzata, non rimane nulla. Molta gente in Europa ancora parla di terrorismo e di continuare la guerra, ma cosa vogliono ancora da noi? Non capisco perché molti vogliono ancora peggiorare la miseria della mia gente, dopo tutto ciò che abbiamo subito. I bambini a Gaza non sanno cosa sono gli aerei civili, hanno visto solo aerei da guerra per tutta la loro breve vita». (carlo trombino)
