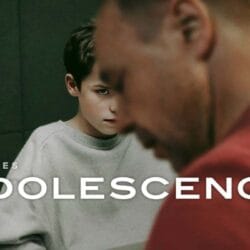
Adolescence
Osservatorio Repressione - Thursday, April 3, 2025Chi più chi meno, temo si sia tutti ostaggio della propria adolescenza, soprattutto coloro che, anagraficamente, l’hanno superata
di Marco Sommariva*
In un articolo di Stefania Garassini pubblicato qualche giorno fa su Avvenire, leggo che Adolescence – la miniserie tv britannica che affronta il tema della violenza tra i teenager, appena uscita e già la più vista sulla piattaforma Netflix – conta “quattro episodi girati tutti in tempo reale (un’ora circa di durata corrisponde esattamente a un’ora di vicenda narrata) e con inquadrature continue che seguono i personaggi in ogni loro movimento con l’effetto di immergere completamente lo spettatore nella storia, evitando di dare alcun giudizio su quanto accade”.
Adolescence è la storia dello sconvolgimento di una famiglia quando il figlio tredicenne, Jamie, viene arrestato per l’omicidio di una sua coetanea, compagna di scuola.
Stefania Garassini prosegue spiegandoci che “sono diversi e tutti cruciali i temi che la serie affronta, dal bullismo, alle dinamiche tossiche all’interno dei social media, all’incomunicabilità tra genitori e figli. Un oceano di dolore che lambisce le vite di tutti i personaggi, senza che sia possibile identificare con certezza un colpevole per il disastro cui si assiste. […] Adolescence invita ad allargare lo sguardo su un mondo adulto che non sembra avere più gli strumenti per capire quanto sta accadendo nelle menti e nei cuori dei propri figli, troppo spesso soli, totalmente immersi nel mondo dei social, dove la derisione e la vergogna possono nascondersi anche dietro le parole e le emoji apparentemente più innocue”.
Su un altro articolo pubblicato da Avvenire, questa volta a firma di Marco Pappalardo, vengono riportate le parole di una studentessa alla quale il giornalista ha chiesto un parere su Adolescence: “Non ero pronta a vedere una storia così violenta eppure così normale oggi. La necessità di sentirsi accettati non si nega e non è solo della mia generazione. Avere le proprie idee, diverse dagli altri, è difficile. Devi essere brava a scuola, educata, obbediente a casa, tra i compagni furba e vestita in un certo modo; devi piacere e condividere storie nel posto giusto. Senza uno di questi requisiti, la vita potrebbe diventare un inferno e per colpa dei social non c’è un posto dove nascondersi. Mi ha sconvolta l’incapacità del protagonista di capire che aveva un’altra scelta. Mi ha spaventato che nessuno abbia chiesto aiuto agli adulti e che essi siano così ciechi e sordi. Questa serie non dà speranze!”
Nell’articolo di Pappalardo, quello sopra non è l’unico commento per bocca dei giovani; altri dicono la loro, come per esempio un certo Marco: “Il contrasto a casa riesce ad isolarci, facendoci sentire soli, impotenti uditori di liti tra adulti. Così giungono delle “consolazioni” che ci distruggono: droga, bullismo, alcool, azzardo, atti criminali. Mi fa riflettere la fragilità umana e la delicatezza dei rapporti”.
Da giorni, sono tantissimi a occuparsi di questa miniserie tv di Netflix: il Corriere della Sera, La Stampa, la Repubblica, Il Messaggero, Il Mattino, Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Libero, Internazionale, L’Espresso, eccetera.
Oltre ai due articoli già citati, Avvenire ne ha pubblicati altri su Adolescence, tra cui quello di Massimo Calvi, il quale ci fa notare che “Il vero motivo per cui tutti in questi giorni stanno parlando di Adolescence […] non risiede probabilmente nella sua elevata qualità di regia e recitazione, e nemmeno nella complessità del tema affrontato, aspetti che in ogni caso ne stanno decretando uno straordinario successo. La ragione più profonda che tiene sulla bocca di tanti la storia del giovane Jamie è legata al fatto che dopo aver visto la serie per intero si manifesta pressante il bisogno di parlarne. Perché è necessario liberarsi di qualcosa, trovare il modo di espellere il disagio condividendolo, superare il trauma attraverso le parole e lo scambio. Adolescence è sì un pugno nello stomaco, come in tanti hanno rilevato – o meglio, sono quattro cazzotti, quante le puntate della serie – ma è soprattutto una forma di abuso, un racconto talmente disturbante per un genitore da richiedere di essere elaborato il prima possibile”.
Ora, anche giustamente, qualcuno di voi s’aspetterà una mia disamina su Adolescence così che anch’io possa liberarmi di qualcosa, trovare il modo di espellere un disagio, superare un trauma attraverso la scrittura di un articolo. No. La mia disamina sarà leggermente diversa, verterà sull’adolescenza di altre epoche cui fanno cenno alcuni scrittori e scrittrici a me cari, anche per capire se, in passato, tutto filava liscio o meno; quindi, tranquilli, non si parlerà della mia adolescenza o di quella “dei miei tempi”.
Intanto, inizierei col dire che sono d’accordo con Laura Pariani quando nella sua raccolta di racconti Il pettine, scrive che “L’adolescenza è una brutta età. […] come un trapezista, devi abbandonare la salda presa dell’infanzia e cercare di afferrare l’appiglio dell’età adulta; e tutto ciò dipende, in un intervallo che mozza il fiato dall’emozione, dall’attendibilità di coloro da cui ti sganci e di coloro che sono destinati a riceverti…”
In Autunno tedesco, Stig Dagerman scrive della Germania dell’immediato dopoguerra, quella del 1946, e dei giovani ci racconta questo: “I ventenni gironzolano per le stazioni delle piccole città fino a quando fa buio, senza avere un treno o qualcosa d’altro da aspettare. Qui si assiste a piccoli, disperati tentativi di furto da parte di adolescenti nervosi che buttano fieramente all’indietro il ciuffo con un colpo di testa quando vengono presi, si vedono ragazzine brille che si attaccano al collo dei soldati alleati e se ne stanno quasi sdraiate sui divani delle sale d’aspetto in compagnia di negri ubriachi. Nessuna gioventù ha mai vissuto un simile destino […]. Hanno conquistato il mondo a diciotto anni, e a ventidue hanno perso tutto”.
Mi verrebbe da dire che gli adolescenti d’oggi hanno perso tutto senza, prima, aver mai conquistato nulla, ma forse la faccio troppo semplice, e allora mi limito a scrivere che questi disperati tentativi di furto da parte di adolescenti e queste ragazzine brille che si attaccano al collo di qualcuno, mi ricordano un po’ troppo da vicino i nostri figli; fosse così, significherebbe che siamo riusciti a devastarli come fossero usciti da una guerra mondiale.
Nel libro Ogni mattina a Jenin di Susan Abulhawa, si racconta la storia di quattro generazioni di palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di “senza patria”, a iniziare dall’abbandono delle case di ‘Ain Hod nel 1948, per il campo profughi di Jenin: “[…] il corpo di Jolanta era stato devastato dai nazisti, che l’avevano costretta a dare gli ultimi anni della sua adolescenza in pasto agli appetiti sessuali delle SS. Quell’incubo le aveva salvato la vita ma l’aveva resa sterile. Avendo perso ogni membro della sua famiglia nei campi di sterminio, Jolanta si era imbarcata da sola per la Palestina alla fine della Seconda guerra mondiale. Non sapeva nulla della Palestina né dei palestinesi, seguiva solo il richiamo del sionismo e le lussureggianti promesse di una terra di latte e miele. Voleva un rifugio. Voleva fuggire dai ricordi di tedeschi sudati che contaminavano il suo corpo, dai ricordi di fame, dai ricordi di depravazione. Voleva fuggire dalle urla di morte che popolavano i suoi sogni, dalle canzoni ormai spente di sua madre e suo padre, di suo fratello e delle sorelle, dalle grida senza fine degli ebrei agonizzanti”.
Non sarà che i nostri figli vorrebbero “semplicemente” scappare dalle urla di morte che popolano i loro sogni, dalle grida di chi agonizza in questi nostri tempi in cui la ricchezza dei miliardari è cresciuta nel 2024 di duemila miliardi di dollari, tre volte più velocemente del 2023, mentre tre miliardi e mezzo di persone vivono con meno di 6,85 dollari al giorno? Non solo, non è che i nostri figli vengono devastati sempre più spesso dagli appetiti sessuali degli adulti o si devastano vicendevolmente pensandosi protagonisti di quei video pornografici da cui si fatica a star distanti e che nessuno ha insegnato loro a studiare, analizzare, verificare, decifrare?
Tra il 1963 e il 1966, Jim Carroll – poeta e musicista – racconta in un diario gli anni della sua adolescenza, scritti che poi diventeranno il libro culto Jim entra nel campo di basket. Quando uscì negli Stati Uniti, rappresentò un caso letterario, suscitando l’entusiasmo di Jack Kerouac; racconta la vita on the road di un ragazzino straordinariamente intelligente, un libro autobiografico, un racconto fedele della sua adolescenza segnata da una precoce dipendenza dall’eroina e dall’esperienza della prostituzione: “Poi ci siamo noialtri ragazzi di strada che cominciamo a cazzeggiare da molto giovani, sui tredici, e crediamo di poter tenere la testa sopra l’acqua e di non prendere l’abitudine. Funziona raramente. Ne sono la riprova io. Così dopo due o tre anni di controllo, finisco nell’ultimo atto: con la scimmia e niente altro da fare che passare tutta la giornata a caccia di droga. In qualunque maniera, va bene tutto, ragazzi. Non ci sono Coste Azzurre e non ci sono mamme ricche da cui correre. Sai quando ci sei dentro definitivamente perché è la volta che svegliandoti la mattina te lo dici chiaro e tondo, senza mezzi termini: Oggi o mi trovo la mia dose o finisco a farmi spaccare il culo ai Tombs, non ci sono cazzi”.
Non so dalle vostre parti cosa stia succedendo, ma qui, dalle mie – a Genova – lo spaccio di stupefacenti è così diffuso che il più conosciuto quotidiano locale, ha dedicato ultimamente numerosi articoli “all’inferno del crack nel Centro città” e, credetemi, sono tantissimi i ragazzi che si alzano da letto decisi a qualsiasi cosa, anche a farsi “spaccare” pur di avere la propria dose giornaliera; fosse così, significherebbe che siamo riusciti a bucarli, intossicarli, stordirli e mortificarli come certi ragazzi eroinomani newyorkesi dei primi anni Sessanta, e senza neppure aver la consolazione di ritrovarli ostili alle mode e alle comparsate televisive come lo era Jim Carroll, appunto.
Nel 1967 viene pubblicato Ora d’aria, la storia di un gruppo di detenuti in un carcere statunitense dove la vita scorre senza tempo: qualcuno è arrivato da poco, qualcuno è dietro le sbarre da anni, qualcuno ci resterà per sempre. Il carcere descritto da Malcolm Braly, l’autore, è un mondo straordinariamente simile a ciò che sta fuori, capace di farci comprendere che tutti, sotto certi aspetti, siamo prigionieri delle nostre esistenze. Braly, abbandonato dai genitori ancora bambino, si dedicherà fin dall’adolescenza a piccole attività criminali, perlopiù rapine, che lo porteranno presto in riformatorio; dei suoi primi quarant’anni, diciassette li trascorrerà nelle più dure prigioni americane: “Si svegliò. Mentre la sensazione del sogno scivolava via, lui ne riconobbe i contorni adolescenziali e gli venne un desiderio nostalgico per quel mondo perduto, le cui aspettative troppo alte avevano avvelenato la sua vita di adulto quando ne aveva scoperto il grigiore”.
E forse qui troviamo un altro aspetto su cui bisognerebbe fermarsi a ragionare un bel po’: le aspettative troppo alte di quel mondo adolescenziale che avvelenano la vita adulta quando se ne scopre il grigiore. Chi genera queste aspettative troppo alte? I genitori? Magari per provare a rifarsi dei propri fallimenti? Magari nel tentativo di “perfezionare” i figli senza rendersi conto che, invece, questa loro deleteria ricerca di perfezione distruggerà i ragazzi? O certe ideologie? Magari quelle che ti promettono ricchezza e benessere se competi contro tutto e tutti e in continuazione? O forse è lo stato? Magari con le sue promesse di sconfiggere nemici, conquistare terre, anche fosse “solo” occupandole culturalmente?
Riprendo la frase di Laura Pariani – “L’adolescenza è una brutta età. […] come un trapezista, devi abbandonare la salda presa dell’infanzia e cercare di afferrare l’appiglio dell’età adulta; e tutto ciò dipende, in un intervallo che mozza il fiato dall’emozione, dall’attendibilità di coloro da cui ti sganci e di coloro che sono destinati a riceverti…” – e mi domando se, noi che di questi adolescenti siamo genitori zii nonni e insegnanti, siamo attendibili o se siamo soltanto corpi che attraversano i giorni con modalità talmente anonima e passiva da garantire agli altri un minimo di credibilità unicamente quando viene pubblicato il nostro necrologio, o se magari la nostra affidabilità l’abbiamo esaurita perché interamente impegnata nel soddisfare il nostro bisogno di far sapere al mondo intero ogni cosa noi si pensi e si faccia postando tutti i nostri palpiti, o se siamo così presi a dispiacerci per i figli adolescenti e per chiunque altro esclusivamente per ignorare noi stessi, la nostra inattendibilità.
L’adolescenza è l’unico periodo della vita in cui non si è sopraffatti dalla nostra adolescenza, è un santuario dove alcuni trascorrono tutto il loro tempo anche mentre i capelli s’ingrigiscono. Forse perché è quel periodo della vita tanto bello quanto tormentato, in cui l’innocenza dell’infanzia non è ancora stata contaminata dall’età adulta e si riesce ancora a immaginare un futuro a colori.
Chi più chi meno, temo si sia tutti ostaggio della propria adolescenza, soprattutto coloro che, anagraficamente, l’hanno superata.
*scrittore sul sito www.marcosommariva.com tutte le sue pubblicazioni
Osservatorio Repressione è una Aps-Ets totalmente autofinanziata. Puoi sostenerci donando il tuo 5×1000
News, aggiornamenti e approfondimenti sul canale telegram e canale WhatsApp
